Filosofia della cultura
L. Garofalo, “Intrecci schmittiani” (Il Mulino 2020)
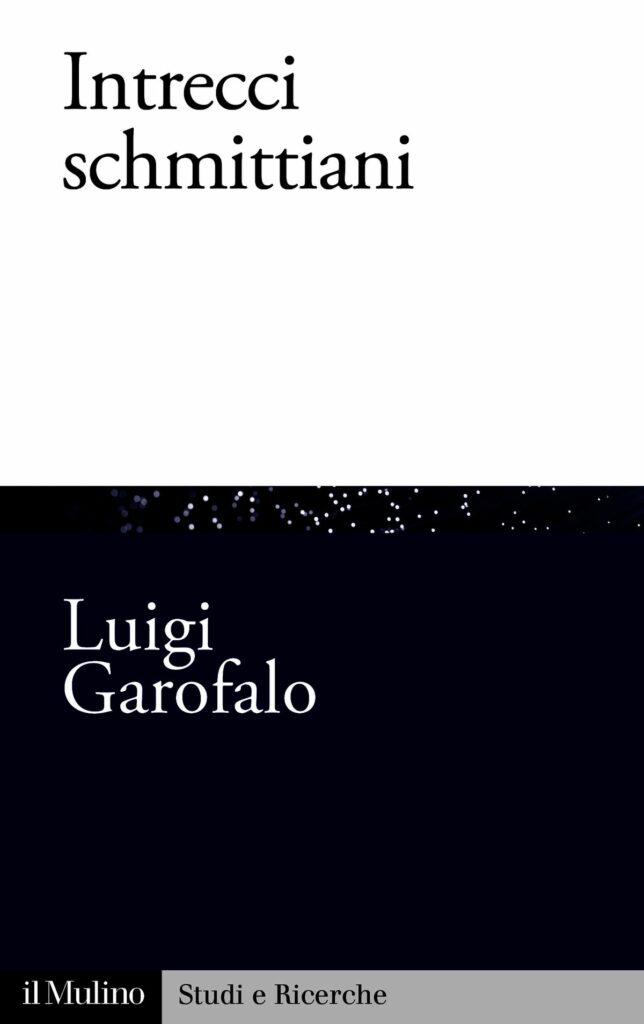
Non potremmo studiare Schmitt, per una volta, concentrandoci proprio e soltanto su Schmitt? Vorremmo affrontarlo, per una volta, senza trovarci costretti ad allargare lo sguardo sino ad abbracciare i tre quarti dell’inteligencija europea: prendiamo Legge e giudizio, e ci viene da pensare a Kandinskij; sfogliamo la sua Teologia politica e la mente corre al saggio di Benjamin sulla violenza, e avanti così. Ma davvero si devono conoscere anche Däubler e Bachofen per comprendere la Dottrina della costituzione? In fondo – ci si potrebbe chiedere – che cosa c’entra L’uomo senza qualità con la definizione della sovranità in Schmitt?
C’entra, c’entra! Lo si può cogliere bene leggendo Intrecci schmittiani (il Mulino, 2020), di Luigi Garofalo, ordinario di Diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo all’Università di Padova, sempre piuttosto incline a “intrecciare” ambiti del pensiero solitamente destinati – purtroppo – a rimanere tra loro separati: si pensi a Biopolitica e diritto romano (2009), a Rubens e la devotio di Decio Mure (2017), e a un altro suo “intreccio” più recente come Echi del diritto romano nell’arte e nel pensiero (2018).
In queste pagine i nessi tra il pensiero di Schmitt e alcune grandi figure dello spirito europeo non rimangono “vaghi”, non sono affidati alla suggestione di analogie più o meno remote. Prendiamo il caso appena citato, Schmitt e Musil: “la loro concordanza è suffragata dalla centralità che entrambi assegnano all’eccezione”. Perciò la nozione di sovranità c’entra con Musil, e c’entra molto. Oppure, per offrire soltanto un altro esempio, Schmitt e la scienza: la crisi dei fondamenti che si respira a inizio Novecento in ambito matematico-scientifico presenta più di qualche somiglianza rispetto alla diagnosi schmittiana sull’improrogabilità di quell’ordinamento giuridico statale che chiamiamo jus publicum europaeum – e qui Garofalo cita le pagine di Rückblicke relative allo stupore e alla meraviglia che la notizia della disintegrazione dell’atomo suscitò nell’animo di Kandinsky. Né, d’altra parte, tutte le analogie possono essere considerate valide: c’è ben poco di espressionista nel pensiero giuridico e politico di Schmitt, malgrado tutta la sua ammirazione per Däubler – come si sa superiore a quella che il giurista di Plettenberg nutrisse per lo stesso Rilke.
Insomma, noi vediamo questo “cantore della scienza giuridica europea” che per un verso incita alla battaglia contro il diritto romano – inteso come primo colpevole della deriva normativista – e per l’altro rivendica il ruolo della scienza giuridica quale ultimo asilo del diritto che ne tuteli l’unità e la coerenza di fronte all’eccesso di produzione giuridica, rifiutando la “gara di corsa con il metodo del decreto legge e dell’ordinanza”. Di qui il riferimento alla personalità di Savigny, e di Bachofen: senza mai sposarne in pieno le tesi, perché il quadro è mutato, non si può restaurare nulla – e una verità storica è vera solo una volta – certo l’Epimeteo cristiano sembra quasi voler chiamare a raccolta quell’insieme eterogeneo di saperi in cui si possa ancora avvertire la presenza di una certa sensibilità, quella capace di distinguere tra legalità e legittimità, e dunque quasi istintivamente contraria allo scatenarsi del tecnicismo. Proprio sul nome di Bachofen, i fili di Schmitt tornano a intrecciarsi con quelli di Benjamin, cui si dovrebbero aggiungere altri fili, quelli di Kerényi, di Fromm, di Horkheimer, e per altri versi di Kleist.
Vorremmo riprendere un punto che diviene decisivo nello sviluppo del testo, vale a dire la “profonda inimicizia” che Schmitt coltivava nei confronti del diritto romano: in quel “diritto internazionale” ante litteram, astratto e individualistico, ravvisava il fattore imprescindibile, quasi l’amalgama capace di governare il “caos di razze” tipico dell’età imperiale e tardoantica. In alternativa il popolo tedesco avrebbe generato un diritto fondato sull’omogeneità della comunità, su una purezza biologica che si opponeva al modello romano. Non è necessario ricordare quanto antica e radicata fosse l’avversione nei confronti della latinità all’interno della cultura tedesca: da qui partirebbero altri intrecci, che ci condurrebbero alla caduta del Sacro romano impero nel 1806, ai Discorsi alla nazione tedesca di Fichte del 1808; in quegli stessi anni all’interno della scuola storica nacque l’ala dei germanisti, tra cui bisogna annoverare anche Jacob Grimm, e il suo scritto del 1816, Sulla poesia nel diritto, dove risalta l’analogia tra il giurista e il poeta, quali “interpreti dei valori spirituali della collettività”. E come negare che questi fili non tornino a intrecciarsi nella nozione schmittiana di sovranità? A questo proposito si aprirebbero anche altri spazi, per ulteriori intrecci, a partire dal saggio di Heidegger Poeticamente abita l’uomo, dove nel Dichten accade la prima “presa di misura”, l’atto fondamentale di misurare la terra. Anche se forse il testo che più si presta all’intreccio sarebbe Wozu Dichter?, considerando che senza dubbio anche Schmitt avvertiva chiaramente di vivere in dürftiger Zeit.
Torniamo all’avversione verso il diritto romano: senza mezzi termini si deve dire che le norme arcaiche, puramente “germaniche”, si rivelarono insufficienti a costituire un sistema giuridico compiuto, così – suggerisce l’autore – Schmitt e i suoi colleghi individuarono fonti inedite del diritto, come il programma del partito e gli ordini del Führer; anche perché la nozione di Volksgeist tanto cara a Savigny era destinata a rimanere piuttosto oscura.
Ma la domanda è un’altra: accreditando l’idea di un diritto del popolo, scaturito dal suo stesso spirito, la scuola storica ha contribuito – e in quale misura? – al sorgere di un sentimento prima e poi di una dottrina giuridica nazionalsocialista, in seguito declinata, grazie anche all’opera di Schmitt, in un regime politico totalitario? Allora la riabilitazione del diritto romano, sostenuta da Schmitt per lo meno a partire dal 1943, forse anche prima, è frutto solo di opportunismo? Oppure no, è frutto di una sincera valutazione? L’autore non ha dubbi sull’autenticità della svolta, e documenta ampiamente la propria tesi, mostrando come Schmitt abbia poi cercato di ricostruire la gloriosa tradizione del diritto romano rintracciandone le manifestazioni più significative lungo l’arco dell’intera tradizione europea, inclusa la ricezione tedesca.
Proprio alla luce della prognosi di Schmitt sul crollo del nomos della terra che aveva regnato per oltre quattro secoli viene da chiedersi: nel diritto romano dobbiamo scorgere il modello per antonomasia dello jus gentium che prima o poi un qualche impero riuscirà di nuovo a imporre, sta volta su scala globale? Oppure lo dobbiamo intendere come il prototipo dello sradicamento che già in epoca ellenistica ha privato la legge della propria “centratura” politico religiosa, della sacralità connessa a un luogo determinato, anticipando di fatto la nostra “globale-Zeit”?